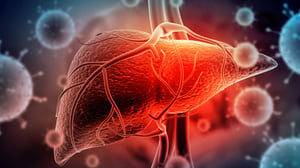Un’ équipe USA ha individuato il modo in cui il virus dell’epatite entra nel fegato: è un percorso simile, per certi aspetti, a quello del coronavirus SARS-CoV-2. Ora diventa possibile il vaccino.
La pandemia e la conseguente, affannosa ricerca di farmaci e vaccini contro il COVID-19, che ha attirato molti investimenti e ricercatori, ha rimesso in movimento tutta la virologia, un settore che, prima del 2020, era diventato relativamente di nicchia.
Accanto agli studi sul coronavirus, si stanno infatti sviluppando con maggiore frequenza e completezza anche le ricerche su altri virus, soprattutto su quelli che presentano ancora molti aspetti oscuri. Tra questi, uno dei più diffusi e dannosi è senza dubbio il virus dell’epatite C (chiamato, in sigla, HCV), contro il quale non esistono vaccini anche se sono disponibili, da qualche anno, farmaci efficaci. I quali, tuttavia, sono costosi e non privi di effetti collaterali.
Covid-19 ed epatite C due virus “simili”
L’assenza di vaccini era giustificata dai punti di domanda ancora esistenti sulla biologia di questo virus, e sulle difficoltà legate alla sua coltura in laboratorio, che ha sempre ostacolato la conduzione di esperimenti approfonditi. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare, perché i virologi del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) statunitense hanno descritto per la prima volta nel dettaglio come avviene l’ingresso del virus nella cellula ospite, e indicato così un possibile punto di attacco per nuove strategie vaccinali e terapeutiche.
Come illustrato sulla rivista scientifica Nature, il virus dell’epatite C si comporta in modo simile al SARS-CoV-2 (il virus responsabile della malattia COVID-19), e cioè si serve di una proteina posta sulla sua superficie, chiamata E2 (paragonabile alla spike del coronavirus), per agganciarne un’altra posta sulla superficie delle cellule umane, chiamata CD81 (assimilabile al recettore ACE2, che interviene nel caso del coronavirus).
Una volta che il legame è realizzato (evento agevolato da un ambiente cellulare acido), la E2 cambia conformazione spaziale, e in questo modo si dispone per favorire l’entrata del virus nella cellula ospite.
Se si riuscissero a realizzare anticorpi monoclonali specifici contro la proteina E2, tipica del virus, così come accaduto con la spike, oppure a istruire l’organismo affinché la riconosca e sviluppi esso stesso anticorpi specifici contro di lei, come accade con i vaccini anti COVID-19, probabilmente il virus dell’epatite C diventerebbe una minaccia relativa, e forse si potrebbe procedere a una vaccinazione di massa.
Una malattia difficile da identificare
Si stima che l’epatite C colpisca circa 70 milioni di persone nel mondo, evolvendo verso la fibrosi, la cirrosi e la necessità di un trapianto in almeno metà dei contagiati. Si trasmette attraverso il sangue (per esempio, in seguito all’uso di siringhe infette), ma resta per molti anni asintomatica, continuando a danneggiare il fegato e, al tempo stesso, a diffondersi da una persona all’altra attraverso l’ospite che, inconsapevole della malattia, è però contagioso. Quando poi il virus dà segni di sé, molto spesso è tardi, e la situazione del fegato compromessa. Per questo la ricerca di un vaccino è da tempo considerata prioritaria.